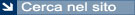Recensioni
Una piaga ancora aperta
Un libro sulle leggi eversive del Risorgimento: liberali e massoni contro la Chiesa cattolica
di Carmelo Capizzi (*)
A prima vista, si potrebbe temere che il libro di cui ci occupiamo sia un tentativo denigratorio del nostro Risorgimento e dei suoi fautori; anche se questi ultimi si riducono a un gruppo di "patrioti", attivi come parlamentari nel Regno di Sardegna tra gli anni immediatamente anteriori al 1848 e la vigilia della seconda guerra d’Indipendenza (1859).
È il periodo in cui a Torino, Carlo Alberto, dopo anni di politica ondeggiante, concede la Costituzione invocata dai "liberali", si mette a capo del movimento patriottico italiano, dichiara guerra all’Austria; ma poi, sconfitto, abdica e lascia la corona a suo figlio Vittorio Emanuele II, ventottenne. Ma gli lascia pure tutto il peso della disfatta subìta a Novara (23 marzo 1849) e tutta la responsabilità della scelta di voler essere l’unico monarca italiano che faccia proprie le aspirazioni di unità e indipendenza dell’Italia intera.
Il nuovo re sapeva bene che non era facile portare un peso simile. Ma, erede delle ambizioni paterne, accettò tutti i rischi del ruolo nazionale e internazionale che assumeva. Rischi e ambiguità. Per contare sull’appoggio dei sudditi rappresentati dal Parlamento e dai governi, da esso man mano costituiti o almeno condizionati, il "re galantuomo" doveva addossarsi l’obbligo di ratificare leggi e iniziative, che venivano proclamate "liberali" e "patriottiche", ma che in realtà spesso ripugnavano alla sua volontà di monarca, sia pure "costituzionale", e alla sua coscienza di cattolico, legato alle tradizioni religiose dei suoi avi. Tra coloro che emergevano nel promuovere leggi e iniziative simili c’erano uomini come Massimo d’Azeglio, Urbano Rattazzi e, soprattutto, l’abilissimo e geniale Camillo Benso conte di Cavour. Essi e i loro collaboratori, comunque, resi pensosi dal fallimento delle varie rivoluzioni scoppiate nella Pensiola nel 1848, e incoraggiati dal successo di felici intuizioni di politica interna ed estera, contribuirono efficacemente all’attuazione dei sogni politici del figlio di Carlo Alberto. Il 17 marzo 1861 Vittorio Emanuele II fu proclamato re d’Italia; il 9 gennaio 1878, morì a Roma, capitale del nuovo Regno; capitale monarchica, a gran dispetto, non solo di molti cattolici "temporalisti", ma anche dei repubblicani che con Mazzini avevano sognato e programmato la "Terza Roma", la "Roma del popolo", per cui si era battuto anche Garibaldi.
Sono fatti, questi, universalmente noti; narrati e studiati da una produzione storiografica immensa, sia italiana sia straniera; molto spesso segnata da voli celebrativi ma non senza dimenticanze o reticenze imbarazzanti.
Solo a denti stretti si dice che i "liberali" subalpini, fortemente divisi tra loro, urtarono contro una notevole opposizione dei "non liberali"- anch’essi tutt’altro che monolitici, fra cui emerse il conte Clemente Solaro dalla Margarita: ma tale opposizione non riuscì con le sue proposte e le sue critiche né a impedire né a modificare essenzialmente le leggi e le iniziative degli avversari, molto meglio organizzati, molto più chiassosi e molto più spregiudicati nel pensare e nell’agire.
Si pensi che i "liberali" erano soltanto una frazione di un Parlamento che, ancora nel 1855, rappresentava soltanto l’1,70% della popolazione globale del Regno sardo, perché gli aventi diritto al voto erano per legge 90 mila 839 persone su un totale di 4 milioni 325.666 cittadini. Le masse - e i loro diritti e interessi - non contavano nulla. Lo stesso Cavour affermava che in Parlamento non aveva senso appellarsi alle masse, le quali "non sono e non possono essere legalmente rappresentate" (pp.160-161).
Nonostante la loro esiguità numerica, i "liberali" pretendevano di essere i soli ad incarnare gli ideali e le forze della civiltà moderna, e di rappresentare tutto il popolo del Regno… Erano convinti di essere gli unici "illuminati", gli unici seguaci della "ragione", gli unici rappresentanti dei "nuovi tempi", i veri promotori del "progresso" nelle scienze, nelle arti e nelle lettere. Gli altri erano spregevoli "retrogradi", "codini", "sanfedisti", "oscurantisti" ecc. - gente che meritava soltanto d’essere imbavagliata o eliminata dalla scena politica, sia pure ricorrendo a leggi persecutorie, mascherate, naturalmente, di patriottismo e di "libero pensiero".
Ma quali erano le idee e gli uomini, di cui si voleva "sbrattare" la nuova società?
I "liberali" subalpini, come quelli di altre parti d’Italia e d’Europa, non ebbero dubbi: le idee da cancellare erano le dottrine della Chiesa cattolica; per conseguenza, gli uomini da far tacere e rendere innocui erano i cattolici sostenitori di quelle dottrine. Così non fu difficile trovare come primo bersaglio coloro che erano considerati i difensori più accaniti e agguerriti delle vecchie dottrine cattoliche, i gesuiti, che, dopo la soppressione del 1773, erano rinati nel 1814 . Contro i gesuiti si scatenò allora - e non solo nel Regno sardo, ma in quasi tutta l’Italia - una campagna di vecchie accuse generiche, o semplicemente calunniose e contraddittorie. Tra i loro accusatori si schierò l’abate filosofo e statista Vincenzo Gioberti, pubblicando libri che, se oggi fanno sorridere, ai suoi tempi furono presi sul serio ed ebbero un successo travolgente. Dopo i gesuiti, venivano i membri degli altri Ordini religiosi e delle Congregazioni maschili e femminili, che, a giudizio dei "liberali", vivevano secondo princìpi inconciliabili coi nuovi tempi.
Era logico che una lotta del genere non dovesse risparmiare i preti e i vescovi. Fu sintomatico il caso dell’arcivescovo di Torino, Mons. Luigi Fransoni, che, a causa della sua fermezza e coerenza nell’opporsi a una legge del Siccardi contro la giurisdizione ecclesiastica (1850), finì in esilio a Lione, donde continuò fino alla morte a governare per dodici anni la sua arcidiocesi.
Nel giugno del 1848 il deputato Alessandro Bixio presentò una legge che fu poi emanata il 25 agosto dello stesso anno. La legge dichiarava illegali e discioglieva tutte le comunità religiose dei gesuiti, delle "gesuitesse" (Dame del Sacro Cuore) e di alcune Congregazioni maschili definite "affiliazioni gesuitiche" oppure "Ordini gesuitanti" (pp. 16-49). Il 29 maggio 1855, dopo una lunga preparazione risalente al 1850, fu pubblicata una nuova legge che coinvolgeva altri 21 Ordini e Congregazioni maschili e 13 femminili. In questo secondo caso il governo di Torino chiuse "335 case, per un numero totale di 3.733 uomini e di 1.756 donne, in tutto 5.489 individui" (pp. 196-197), calpestando i loro diritti civili più elementari. Superfluo dire che anche in questo caso - come si era fatto nel 1848 coi gesuiti e con gli altri - a tutte le comunità disciolte vennero confiscati i beni, compresi gli archivi e le biblioteche. I loro edifici conventuali o monastici, come i loro beni terrieri, o furono reimpiegati a scopi pubblici profani (caserme, scuole, municipi, tribunali, ospedali…) o vennero venduti o, meglio, svenduti a privati, cioè a borghesi e aristocratici - in gran maggioranza "liberali", beninteso. Tutta l’operazione provocata da tali leggi eversive ebbe, fra l’altro, tre effetti: 1) l’impoverimento di ampi strati del mondo contadino, costretto a pagare ai nuovi padroni canoni molto più pesanti di quelli che pagava al clero; 2) il degrado di tanti monumenti sacri e di tanti edifici monastici ed ecclesiastici destinati a ospitare non solo caserme, carceri, tribunali, municipi, ma anche case coloniche, depositi, magazzini, stalle, ecc.; 3) la dispersione o distruzione di grandi raccolte librarie e archivistiche, spesso ammucchiate alla rinfusa e lasciate in balia dell’ignoranza e della pigrizia dei burocrati.
Una guerra di religione
Così, il Regno sardo si era messo a scimmiottare la Francia Rivoluzionaria e napoleonica di mezzo secolo prima - e a preludere a certi regimi totalitari di destra e di sinistra di circa un secolo dopo - perseguitando a morte la Chiesa cattolica e tentando di giustificarsi con scampoli di teologia protestante, frammenti di giurisdizionalismo assolutistico e antipapale, rimasticature di illuminismo enciclopedista. Tutto veniva mascherato, naturalmente, con la "modernità", col "progresso", col "bene del popolo", con la "risurrezione della patria", ecc. ecc. (pp. 147-161).
Tale persecuzione, fatta specialmente di confische, era dettata da necessità economiche proprie del Piemonte sconfitto dall’Austria; ma era anche suggerita dall’ingordigia della classe dirigente subalpina, nelle cui mani si spostarono grandi porzioni dei beni confiscati. Soprattutto era ispirata dalle logge massoniche, le quali, come spesso andavano proclamando chiaramente, colpendo gli Ordini e le Congregazioni religiose, intendevano colpire la Chiesa cattolica, che speravano di cancellare giungendo all’abolizione dello Stato pontificio e… del Papato.
I noti elogi ottenuti da tale politica del Regno savoiardo da parte di statisti inglesi dichiaratamente anticattolici, come Lord Henry John Palmerston (1784-1865) e Lord Bejamin Disraeli (1804-1881), sono molto significativi.
Da oltre un secolo e mezzo, ad onta della massa dei documenti dati alle stampe o rimasti manoscritti in tante biblioteche e in molti archivi pubblici e privati, si è cercato e spesso si cerca tuttora di nascondere o di minimizzare proprio questo fatto macroscopico. Si tenta di coprire che il Risorgimento italiano da alcuni dei "liberali" più lungimiranti e attivi fu concepito, in ultima istanza, come una guerra di religione, una crociata contro la Chiesa cattolica.
La Pellicciari, autrice del libro, prova l’acre piacere di esporre alla luce del sole una realtà storica che sta alla radice di disfunzioni politiche, economiche e sociali, ancora visibili nell’Italia odierna. Essa si è fondata soprattutto sugli atti del Parlamento subalpino, sui carteggi dei politici protagonisti e su altri documenti d’archivio, spesso trascurati o ignoti. Ma ha saputo pure tener sott’occhio la stampa ottocentesca italiana e straniera, come pure la storiografia più autorevole, tradizionale o meno. Nondimeno, il libro, a saperlo leggere, non lascia indifferenti o tranquilli. Il lettore vi "inciampa" spesso in notizie inedite e talora sconvolgenti e "demitizzanti", che lo spronano ad approfondire questo o quel tema del nostro Risorgimento, la cui storia, come denunciava all’inizio del nostro secolo Giovanni Papini, si trova "ancora nello stato di cromolitografia" - cioè di ricostruzione varia e provvisoria. Una grave lacuna è la mancanza di un buon indice dei nomi e delle materie.
Carmelo Capizzi
ANGELA PELLICCIARI, Risorgimento da riscrivere. Liberali & massoni contro la Chiesa, Milano, Ares, 1998, pp. 324, L. 38.000
(*) Padre Carmelo Capizzi, S.J., Docente di Storia bizantina presso la Terza Università di Roma.